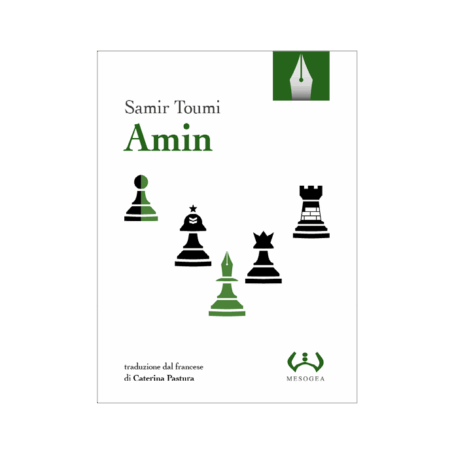Samir Toumi, lo scrittore che fa dialogare intimità e politica

Riportiamo nel nostro Portolano la traduzione dell’intervista a Samir Toumi, realizzata da Djamal Guettala e pubblicata il 13 giugno 2025 su Le Matin d’Algérie.
Si ringraziano per la collaborazione Djamal Guettala, Samir Toumi e la redazione de Le Matin d’Algèrie.
Amin, une fiction algérienne (barzakh, 2024), ultimo romanzo di Samir Toumi, tradotto in italiano da Caterina Pastura, sarà in libreria col titolo Amin a settembre 2025.
* * *
Il suo nuovo romanzo s’intitola Amin, une fiction algérienne. Perché questo sottotitolo?[1] Cosa c’è di finzionale e di algerino in questa storia?
Il sottotitolo rispecchia profondamente lo spirito del romanzo. Si tratta di una storia d’invenzione; tutto parte da un patto tra Djamel B., scrittore a corto di ispirazione, e un certo Amin, personaggio enigmatico incontrato durante una serata mondana. Amin propone qualcosa di inaspettato: che Djamel scriva un romanzo ispirato al suo mondo, alla sua carriera, alla conoscenza diretta che ha del cosiddetto sistema. E insiste, vuole un’opera narrativa, non un saggio, né un articolo giornalistico. Il romanzo, secondo lui, consente una maggiore libertà, di voce e di forme espressive, l’unica che può rendere la complessità di ciò che ha vissuto. Djamel, intrigato e al contempo turbato, persino intimorito da Amin, nonostante tutto, accetta lo strano patto. Quanto al termine «algerina», s’impone per forza di cose: la vicenda si svolge in Algeria, ad Algeri per l’esattezza. Si parla del paese, delle sue contraddizioni, delle sue zone d’ombra, di questo famoso sistema. Il romanzo dunque pone in questione, in fondo, il modo in cui la finzione narrativa può dire la realtà – e ciò che questa realtà ha di profondamente algerino. Il sottotitolo ha anche lo scopo di suscitare una qualche forma d’interrogazione nel lettore. Completa un titolo molto semplice, Amin, e lo apre a qualcosa di più ampio, politico e letterario insieme.
Dalle prime pagine si percepisce che Amin è un personaggio in crisi, stretto tra diverse realtà. Cosa l’ha spinta a scrivere su questo contrasto interiore?
Più che parlare di un personaggio in crisi, direi che ciò che lei percepisce come lotta interiore è innanzitutto interrogarsi sulle proprie intenzioni. E questo è molto interessante poiché rispecchia la sua lettura, la sua proiezione come lettore, che considero sempre una cosa preziosa. Fin dalle prime pagine del romanzo, aleggia una domanda: chi è veramente Amin? Perché vuole che Djamel scriva questo romanzo? Sta cercando di denunciare qualcosa? Di trasmettere una testimonianza? Di regolare dei conti? Una cosa è certa: ha intenzioni precise, ma non le rivela mai completamente. Ed è questa sua parte d’ombra che intriga Djamel. Lo turba, ma lo cattura. Djamel, da scrittore, reagisce un po’ come uno squalo che sente l’odore del sangue: è irresistibilmente attirato. Anche se non gli è tutto chiaro, sente che c’è una materia viva, complessa, scottante – e lui ha bisogno di scrivere. S’imbarcherà dunque in quest’avventura letteraria, malgrado i dubbi, le zone d’ombra. Perché uno scrittore spesso scrive a partire da ciò che ancora non ha compreso del tutto.
I suoi romanzi sembrano sempre richiamare Algeri come scenario ma anche come specchio interiore. Che ruolo ha la città in Amin?
In effetti Algeri ha un posto centrale nei miei scritti, fin dal mio primo racconto, Alger, le cri [Algeri, il grido, Astarte 2023]. Questo libro era una sorta di proiezione del mio dialogo interiore con la storia e il presente della città. Vagare per Algeri mi permetteva allora di mettere in questione il mio posto nel mondo, la mia storia personale, ma anche la storia collettiva a cui appartengo. Camminare ad Algeri era cercare parole, tentare di «partorire» un discorso mentre andavano passi e pensieri. In Amin Algeri c’è ancora, ma in una versione molto particolare: quella mondana, sfarzosa, l’Algeri dei salotti, degli ambienti esclusivi, delle apparenze. È questo il microcosmo in cui si muove Djamel B., lo scrittore. Ed è attraverso i suoi occhi che la città viene osservata, scrutata, quasi poetizzata. Anche attraverso le sue contraddizioni, infatti, Algeri conserva per me una grande potenza evocativa. Più in generale, la città ha sempre un ruolo essenziale nella mia scrittura. In L’effacement [Lo specchio vuoto, Mesogea 2018] ho allargato il raggio a Orano, che il personaggio principale, essendo uscito molto poco dal proprio universo, scopre da turista maldestro. Ma ai miei occhi Algeri rimane una inesauribile fonte di ispirazione. È una città intensamente visiva, ti fa venire voglia di descriverla, di perdercisi, di seguire con lo sguardo le sue alture, i suoi edifici, di essere assalito dal caos urbano. È una città che invita alla contemplazione, ma anche all’introspezione.
In questo romanzo si ritrovano echi di Lo specchio vuoto: il tema del doppio, la perdita di sé, la difficoltà ad abitare la propria identità. È un seguito di quel libro in fondo?
È una domanda interessante. In effetti ci sono delle risonanze tra i due romanzi. Forse il legame più evidente sta nei personaggi stessi. Djamel B., lo scrittore, Amin, questa figura misteriosa, e il narratore senza nome de Lo specchio vuoto hanno tutti qualcosa d’instabile, fuori dalle regole. Djamel vive in un ambiente mondano, pubblica romanzi ma avvertiamo immediatamente che non è felice. È travagliato dalle dipendenze, dal continuo girovagare, da una sorta di vuoto. Serviva un personaggio come lui, un tipo po’ perso, perché potesse lanciarsi in un’avventura così torbida. Amin, invece, resta indecifrabile. Non si sa veramente chi sia, cosa voglia, né cosa lo spinga a volere questo romanzo. Sembra cercare qualcosa – forse una verità, una redenzione, uno specchio. E qui, ancora una volta, ritroviamo il motivo del malessere, della ricerca d’identità, di un bisogno di definirsi attraverso la parola o la finzione. Ma al di là dei personaggi, quello che collega veramente i miei romanzi, Amin, Lo specchio vuoto, e anche Algeri, il grido, è la volontà di raccontare l’Algeria contemporanea. Di raccontare chi siamo noi, non attraverso discorsi teorici, ma attraverso storie incarnate, profondamente soggettive. Sono sempre stato attirato dalla letteratura che testimonia, che interroga il nostro presente sociologico, politico, storico, ma a partire dall’intimità. Da una voce.
La questione del padre – o piuttosto dei padri – attraversa i suoi libri. Possiamo dire che la sua è opera di scrittura anche contro o con questa figura tutelare?
Si tratta di una figura effettivamente centrale, ma più per la sua esitazione che per la sua stabilità. Il padre, nei miei scritti, è spesso una presenza fragile, incerta, talvolta fagocitante – come in Lo specchio vuoto – di fronte alla quale diventa difficile esistere pienamente. Rappresenta al contempo la guida, colui che trasmette dei valori, ma anche il potere che può soffocare. Incarna la tensione tra eredità e autonomia. È una figura che mi affascina perché attraversa nel profondo la società algerina: il rapporto con «i padri fondatori» dello Stato indipendente, per esempio, ma anche quello con il padre tradizionale di fronte ai mutamenti sociali, in particolare l’emancipazione delle donne. Tra autorità morale, verticale, e crisi di legittimità, la figura del padre si incrina. In Amin questa simbolica si estende alla questione della governance. Lì io metto in questione forme di potere che potremmo definire cachistocrazie, nelle quali la figura del padre – o del leader – diventa fallimentare, inceppata, chiusa nella sua stessa logica. C’è una corrispondenza diretta tra il padre di famiglia e il padre politico, entrambi portatori di un ordine antico in tensione con il presente.
Lei è ingegnere per formazione, fotografo per passione, scrittore rinomato. Come coesistono queste tre dimensioni nel suo processo creativo?
In realtà sono due volte ingegnere – due volte è meglio di una, come si dice – (Sorride). Ma non ho mai esercitato come tale. Il mio mestiere, da più di trent’anni, è quello di consulente nel settore risorse umane. Dirigo una società in Algeria, e questa funzione di consulente e dirigente d’impresa è la mia quotidiana occupazione professionale. Quanto alla fotografia, la pratico da dilettante. Non mi definisco fotografo, è una passione che mi accompagna. Nello specifico, ho una piccola ossessione: fotografare ogni giorno lo stesso luogo. Una maniera, per me, di sottolineare l’impermanenza nella permanenza. Quello che mi lascia particolarmente stupefatto è soprattutto il colore del cielo di Algeri, sempre mutevole. Pubblico queste immagini sui social come una sorta di rituale, discreto, ma intimo. E poi c’è la scrittura. Un giorno ho sentito il bisogno di dire certe cose, di esprimere ciò che mi sembrava importante, comunque importante per me. La scrittura allora si è imposta come un naturale prolungamento del desiderio di capire e testimoniare. Come coesiste tutto questo? Con una certa naturalezza, in effetti. Ho sempre avuto una vita a più dimensioni e la cosa non è mai stata un problema. Ogni dimensione alimenta le altre. Certo, a volte l’impiego del tempo comporta degli obblighi, ma nulla di insormontabile.
La sua è una scrittura molto visiva, quasi cinematografica. Lei «vede» i suoi romanzi prima di scriverli?
Proprio così. Scrivo visualizzando. La scrittura, per me, è innanzitutto capacità di vedere, di sentire, di ascoltare. È una forma di percezione estesa in cui tutti i sensi sono mobilitati: ciò che capta l’occhio, ciò che percepisce l’orecchio, ma anche la consistenza delle cose, gli odori, gli ambienti… e, sicuramente, le emozioni. Sono queste percezioni sensoriali e affettive che cerco di tradurre in parole. Ho un gusto molto deciso, che definirei da «naturalista», per la descrizione precisa, che si tratti di luoghi, di paesaggi, o di personaggi. Amo entrare nei dettagli, nello «spessore del mondo». È una cosa che adoro fare scrivendo, ma anche leggendo altri autori. La visualizzazione è centrale, sì, ma non è mai sola: chiama tutti i sensi e nutre la complessità psicologica dei personaggi, la loro densità, le loro contraddizioni. E, a essere onesto, non faccio veramente distinzioni tra processo letterario e processo artistico in senso lato: cinema, arti plastiche, fotografia, scultura… Per me, la creazione è un processo unico. Nasce dal medesimo movimento: quello di un’emozione, di uno sguardo, di un’esigenza interiore di esprimersi.
In Amin si parla anche di sistema, di potere, di doppiezza. Si tratta di un romanzo politico, anche se dietro la trama apparente di una vicenda personale?
Ho cominciato a scrivere questo libro nel 2018, alla fine del quarto mandato presidenziale. In quel periodo c’era nell’aria qualcosa d’indicibile, una tensione sorda, come se si stesse preparando una transizione. Sentivo il bisogno di descrivere, attraverso l’invenzione narrativa, quello che comunemente si definisce sistema, la sua opacità, la sua complessità, il funzionamento basato su pettegolezzi, reticoli, ruoli ambigui. È un tema su cui m’interrogo da molto tempo. Questo romanzo è nato da numerosi incontri con persone che dichiaravano di essere «vicine al sistema» o di farne parte. Ogni cerchia ha i suoi Amin: non si sa mai veramente cosa facciano, né la funzione esatta che svolgono. Io volevo esplorare questa zona grigia, questa doppiezza, attraverso la letteratura. Che è appunto ciò che rende più sottile, più percepibile, l’approccio politico. Mi sono nutrito di varie letture: saggi, ricerche, lavori sulle forme del potere, sulle cachistocrazie. Inoltre, il mio mestiere, che riguarda la governance d’impresa, mi ha dato delle chiavi di lettura. L’incrocio di realtà politica contemporanea, analisi sociologica e immaginazione letteraria ha plasmato la trama di Amin.
La malinconia attraversa i suoi scritti come una luce sorda. Scelta estetica, o tonalità imposta dai tempi?
Entrambe, probabilmente. La malinconia è un sentimento complesso, e io la trovo interessante, feconda. Abita i miei personaggi perché spesso traduce una forma di sensibilità maggiore, talvolta persino di ipersensibilità al cospetto del mondo. La serietà, il leggero ritrarsi indotti dalla malinconia, mi colpiscono. È una tonalità su cui amo lavorare come scrittore, dal momento che offre singolare profondità allo sguardo che portiamo sulle cose. Di sicuro, tuttavia, c’entrano anche i nostri tempi. Che oggettivamente non sono allegri, anche se le nostre vite quotidiane possono ancora essere colmate da piccole semplici felicità, che in fondo sono forse le più essenziali. Cionondimeno, se si fa un po’ un passo indietro rispetto al modo in cui procede il mondo, la malinconia può far presto a chiudere la stretta. E a volte anche a lasciare il posto a emozioni ancora più vive, come la rabbia o il senso di impotenza. Di fronte a questo, sono convinto che la sola risposta possibile sia l’azione. Creare, continuare ad andare avanti, a fare cose che siano belle. Ciascuno nel proprio ambito, ciascuno a modo proprio, ma con la stessa energia vitale. La scrittura, per me, è una maniera di abitare questa malinconia senza annegarci dentro.
Il suo Lo specchio vuoto è stato adattato per il cinema. Le piacerebbe vedere Amin portato sullo schermo?
Sì, certo. Lo specchio vuoto è stato adattato da Karim Moussaoui, un regista il cui lavoro ho già avuto modo di apprezzare, soprattutto per Les jours d’avant e En attendant les hirondelles. È stata una grande gioia per me, tanto più che si trattava di un libero adattamento. Karim ha creato la sua storia a partire dal romanzo, seguendo la direzione singolare che gli era consona. Ed è proprio questo che mi ha colpito profondamente, vedere come una materia letteraria possa trasformarsi in opera cinematografica autonoma, forte, sconvolgente. È un film che consiglio vivamente. Per quanto riguarda Amin, sì, chiaramente; quale autore non sognerebbe di vedere quanto ha scritto adattato per lo schermo? Diversi lettori mi hanno già confidato che il romanzo ha qualcosa di molto visivo e che potrebbe decisamente diventare un film, o anche una serie televisiva. Penso che un romanzo, una volta pubblicato, segua una sua traiettoria. Diventa un oggetto vivo che appartiene anche ai lettori. E se questa traiettoria dovesse passare per un adattamento cinematografico, ne sarei molto onorato. Sarebbe una nuova vita offerta al libro, e una nuova lettura, con un altro sguardo.
La letteratura algerina contemporanea esplora vari territori: l’intimità, la memoria, il sociale, l’esilio. In questo paesaggio, lei dove si colloca?
Dalla parte dell’intimità, della memoria e del sociale, è chiaro. L’esilio, invece, non è al centro della mia scrittura, anche se talvolta sfioro la questione del desiderio di fuga. In Algeri, il grido, per esempio, questo tema attraversa il racconto, ma si tratta più di un desiderio di cambiare vita che di esilio geografico. Si tratta di quel momento di oscillazione interiore in cui ci si chiede: «Voglio partire veramente, o voglio semplicemente vivere in un altro modo?». È una domanda universale, ma anche legata molto alla condizione contemporanea in Algeria. Quel che cerco di esplorare è appunto questo cammino interiore: come si crea una possibilità per sé, come ci si inventa una vita vivibile in un mondo a volte costrittivo. Più in generale, e al di là dei temi che affronto, mi riconosco pienamente in ciò che viene definita letteratura algerina contemporanea. Ne faccio parte, come scrittore algerino, accanto a numerosi altri autori, sia arabofoni, sia francofoni. Quello che ci lega, in fondo, è questo territorio immenso, l’Algeria, in quanto spazio reale e, allo stesso tempo, in quanto materia letteraria. Un rigoglioso luogo di sperimentazione attraversato da una storia densa, un presente complesso e un futuro a cui cerchiamo di pensare. È questo substrato collettivo che condivido con i miei contemporanei e che non ho mai finito di esplorare.
Qual è, a suo avviso, il ruolo dello scrittore, oggi, in Algeria?
Tre cose, mio capitano! Senza esitazione: testimone, vedetta, perturbatore. Di certo, non elargitore di lezioni! Lo scrittore non è qui per spiegare tutto, né per asserire verità definitive. Non ha la vocazione di sapere tutto, né di comprendere tutto, o di esprimere un parere su tutto. Diffido di questa postura da intellettuale onnisciente. Ciò che mi interessa è lo scrittore in contatto con il proprio tempo, attraversato dai suoi dubbi, dalle sue domande e contraddizioni. Uno scrittore che osserva, che capta deboli segnali, che domanda senza imporre. Uno che talvolta è perturbante ma senza cercare lo scandalo; per il semplice fatto di nominare cose che altri preferiscono tacere.
Se dovesse rivolgersi a un giovane lettore algerino che ancora non la conosce, cosa gli direbbe per invitarlo a entrare nel suo universo?
A essere molto sincero, non ho grandi cose da dirgli. Entrare in un universo letterario non è affatto un obbligo. Un libro è un incontro. Lo teniamo tra le mani, guardiamo la copertina, forse ci attrae il titolo, forse no. Leggiamo il retro di copertina, ci prende, oppure no. E se scatta qualcosa, apriamo il libro, leggiamo le prime righe. Se c’è risonanza, andiamo avanti. Se no, lo richiudiamo. Semplice. Non ci sono messaggi da consegnare, non c’è nessun invito particolare. Solo libri che attendono di incontrare i propri lettori. E va benissimo così.
[1] [N.d.R.]: nell’edizione italiana del libro si è scelto di non riportare il sottotitolo, ma si sono mantenute queste prime domanda e risposta per rispettare la completezza dell’intervista.
Articolo originale: https://lematindalgerie.com/samir-toumi-lecrivain-qui-fait-dialoguer-lintime-et-le-politique/
***
Amin
traduzione dal francese di Caterina Pastura
« In quell’ecosistema perfettamente organizzato, ognuno sembrava occupare un posto ben definito, con una sua precisa utilità, e interpretava con più o meno brio la propria parte. […] chi manovrava i fili? Amin che ruolo assumeva: marionetta o marionettista? E io? Di chi ero il pupazzo? »